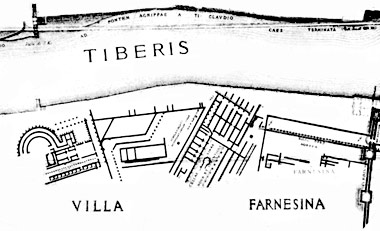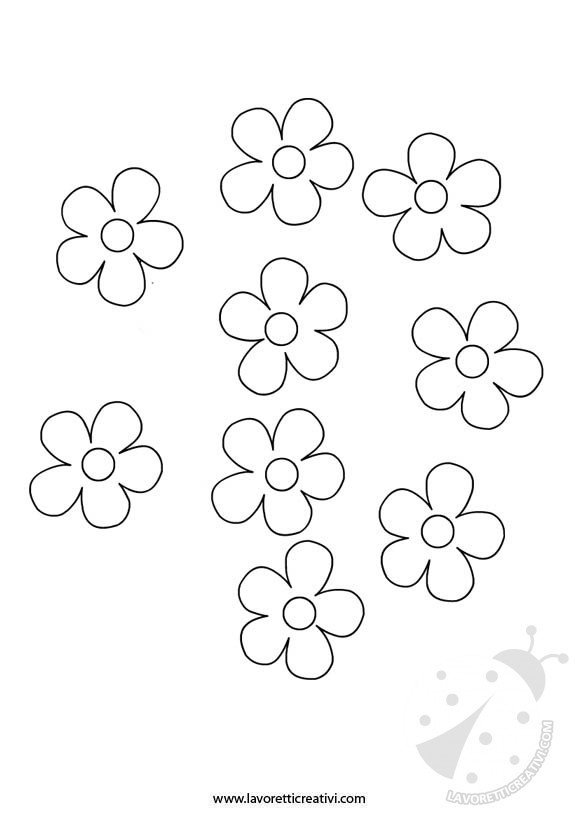E’ recente la notizia che il Ministro Patrizio Bianchi abbia deciso di estendere a 1000 scuole la “sperimentazione” dei percorsi di istruzione di secondo grado in 4 anni. La bozza di decreto di rinnovo ordinamentale, valutata negativamente dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata invece accolta con favore dal Presidente dell’INVALSI, secondo cui i primi risultati provenienti dai licei quadriennali sarebbero “del tutto in linea” con i licei quinquennali, in virtu’, probabilmente, di una efficace “essenzializzazione” della didattica. Per l’INVALSI insomma 5=4: la scuola, se fatta bene, secondo lo standard INVALSI, può essere accorciata di un anno, senza che i risultati ai test ne risentano poi tanto. Ecco la terza parte della critica approfondita e dettagliata alla scelta politica di ridurre di un anno il percorso di studi delle scuole secondarie, che ne evidenzia tutti i rischi e la cattiva retorica.
Terza Parte
1. La terza via, ovvero: come rendere comodo il letto di Procuste
Ma – si dirà – non esiste un terzo scenario? Il decreto di sperimentazione non indica con chiarezza la Via, non fornisce la Chiave, non addita profeticamente la Terra Promessa? La miracolosa conservazione dell’offerta formativa quinquennale, pur riversata in un percorso quadriennale, dovrebbe infatti avvenire, nei desiderata ministeriali, grazie al sistematico impiego di “didattiche laboratoriali”, “nuove tecnologie didattiche” ed “insegnamenti in lingua straniera” (cosiddetto CLIL).
Se si vuole comprendere davvero su quali basi poggi la strabiliante dimostrazione per cui 5=4, il discorso deve entrare in un certo, inevitabile tecnicismo. Vediamo, per quanto possibile in breve.
2. La nuova frontiera: le didattiche laboratoriali
Da qualche tempo, la legislazione nazionale vede nella didattica laboratoriale, come ovvio riferita specialmente a insegnamenti tecnico-scientifici, uno dei principali strumenti salvifici[1]: la scuola del fare, che sarebbe la grande assente dal panorama pedagogico nazionale (a questo punto di solito si inveisce, con riflesso pavloviano, contro Croce e Gentile…), contrapposta polemicamente alla scuola del sapere teorico.
Il sottinteso, non dimostrabile e quindi assunto dogmaticamente: quando lo studente fa, allora impara davvero, impara meglio e impara prima: esaltazione della dimensione dell’agire (irriflesso) di contro all’inutilità del teorizzare, che è poi pensare, visto come strumento didattico inconcludente, noioso, polveroso e sorpassato (con buona pace di Feynman, secondo il quale non v’è niente di più pratico di una buona teoria; con buona pace di 25 secoli di riflessione filosofica e pedagogica). Si tratta, naturalmente e semplicemente, di sciocchezze, ma con il vantaggio non da poco di essere molto in linea con i tempi: che non sembrano chiedere di formare individui pensanti, ma – appunto – operanti. Lasciando pure da parte l’obiezione che una tale impostazione “laboratoriale” richiederebbe più tempo scuola e non meno (per motivi intuibili anche da parte dei non addetti ai lavori): non sarebbe a questo punto lecito chiedere l’esibizione delle ragioni che giustificano tale visione, l’indicazione delle ricerche scientifiche indipendenti che dimostrano la maggior efficacia di “pratiche laboratoriali” nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento?
Per ingannare il tempo, mentre si resta in paziente attesa di tale esibizione, si può andare a leggere un denso articolo di D. Hodson [Ho], ordinario presso l’università di Auckland, che ha condotto un accurato studio della questione sulla base dei dati disponibili nel mondo anglosassone, dedito alla “didattica laboratoriale” da molto più tempo di noi (la raccomandazione del Dipartimento dell’Educazione inglese ad impartire in modo sperimentale l’insegnamento delle scienze è del… 1882!): qui la mole di dati a disposizione dell’analisi è assai ampia. Scrive Hodson: “l’attività pratica, così come è condotta in molte scuole, è mal concepita, confusa e improduttiva. Essa non fornisce un reale valore educativo. [corsivo mio] Per molti ragazzi, quello che fanno in laboratorio non contribuisce sostanzialmente all’apprendimento di contenuti o metodi scientifici, né li porta a fare scienza, almeno in senso significativo.”
Hodson si pone cinque domande, che riassumono sostanzialmente tutte le ragioni che di solito sono addotte a favore della diffusione della didattica laboratoriale: 1) L’attività pratica motiva gli alunni? (…) 2) Gli alunni acquisiscono abilità sperimentali dall’attività pratica scolastica? L’acquisizione di tali abilità costituisce un obiettivo educativo che merita di essere perseguito? 3) L’attività pratica aiuta gli alunni a sviluppare la comprensione dei concetti scientifici? (…) 4) Impegnandosi nell’attività pratica, quale opinione e quale immagine della scienza e dell’attività scientifica si fanno gli alunni? Quest’immagine è una rappresentazione fedele della reale pratica scientifica? 5) I cosiddetti “atteggiamenti scientifici” sono necessari per la buona riuscita nell’attività scientifica vera? Le attività svolte nelle scuole sono adatte a suscitare questi atteggiamenti negli alunni?
La risposta di Hodson a tutte le domande è un sonoro, definitivo NO.
La questione meriterebbe certo ben altri approfondimenti, che questa sede non permette: in relazione a quanto detto, sia perlomeno lecito dubitare fortemente dell’efficacia della “didattica laboratoriale”, tanto più se addirittura intesa come strumento di compensazione della riduzione di tempo scuola. A meno di non intendere “laboriatorialità” come mera attività addestrativa a pratiche operativo-esecutive in cui si fa senza conoscere le ragioni del proprio fare: ma in tal caso si è già molto oltre il perimetro di ciò che finora l’uomo ha tradizionalmente chiamato scuola.
3. Le miracolose nuove tecnologie didattiche
Nel gergo buropedagoghese in voga, il matrimonio tra arte della didattica e strumenti digitali (piattaforme di e-learning, risorse web, software didattici, enciclopedie on line, ambienti di formazione a distanza, lavagne interattive multimediali, portatili, tablet, smartphone, forum, social media, classi digitali, flipped classroom e chi più ne ha…) è indicato con il termine tecnologie didattiche. L’idea che il miglioramento degli apprendimenti passi necessariamente per il potenziamento e la diffusione delle tecnologie didattiche nella scuola è oggi largamente affermata e, coerentemente, ora fatta propria dal decreto di sperimentazione[2]. Sottolineo: non si tratta di una posizione che colloca lo strumento al livello che gli compete, quello appunto di attrezzo da usare con buon senso, quando e se ritenuto utile (eventualmente, dunque, anche da non usare per nulla). Quello di mezzo per raggiungere un fine. No, mi riferisco qui ad una posizione radicale, largamente diffusa, che attribuisce alla tecnologia didattica un ruolo essenziale nei processi di apprendimento, con ciò prefigurando un vero e proprio rovesciamento mezzi-fini. In questo caso, come per la didattica laboratoriale, l’uso delle nuove tecnologie didattiche assume una centralità ed un’essenzialità del tutto nuove e, per così dire, spinte all’ennesima potenza: se è vero che esso viene dichiaratamente inteso come strumento capace di comprimere tanto efficacemente i tempi di apprendimento, da rendere possibile l’eliminazione indolore di un anno di corso.
Anche in questo caso, sorge spontanea la domanda: esistono prove scientifiche indipendenti (pregasi astenersi multinazionali che vendono hardware, software e servizi telematici) che corroborino la tesi secondo cui la sistematica introduzione delle tecnologie didattiche nelle scuole migliori gli apprendimenti? Non solo la risposta sembra negativa, ma esiste addirittura l’evidenza opposta: gli studi a disposizione ci inducono a pensare che portatili e lavagne interattive nella scuola ostacolino il processo di apprendimento e quindi danneggino gli alunni. [Sp] Per quanto riguarda l’uso dei computer con finalità didattiche, pare ben attestato che le capacità di lettura e di calcolo dei soggetti che stanno al computer più volte a settimana sono decisamente peggiori. Lo stesso vale per l’uso di internet a scuola. [FW]
A conclusioni analoghe è giunto un ente al di sopra di ogni sospetto: non querule associazioni di psicologi dell’età evolutiva o di neuropsichiatri, ma addirittura l’OCSE. In una recente pubblicazione [OCSE], infatti, gli esperti dell’Organizzazione internazionale hanno studiato la correlazione tra diffusione dell’ICT (Information and Communication Technology) a scuola e gli esiti dei test standardizzati internazionali PISA in lettura, matematica e scienze. La conclusione? Devastante (ma del tutto in linea con quanto si diceva poco sopra): in estrema sintesi, gli esiti, statisticamente, sono tanto peggiori, quanto maggiore la penetrazione e la diffusione dell’ICT a scopi didattici.
Una bomba atomica, si direbbe. Macché. Noi ci affideremo, fiduciosi, al massiccio uso delle tecnologie digitali per recuperare un anno di corso perduto. Moderna pedagogia del click.
4. La pietra filosofale: il CLIL
Il terzo pilastro che dovrebbe permettere alla “riforma epocale” che si viene prefigurando di evitare sostanziosi impoverimenti culturali è stato introdotto, dall’oggi al domani, dalla precedente “riforma epocale” dell’allora ministro Gelmini (2010), confermato dalla più recente – ed altrettanto epocale – riforma Giannini (convenzionalmente indicata dal battage pubblicitario come “buona scuola”, 2015): all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di II grado, l’insegnamento di una disciplina non linguistica è impartito in lingua straniera (corsi liceali) o in inglese (istituti tecnici)[3]. In parole povere: l’insegnante di (poniamo) scienze insegnerà la propria materia nel… proprio inglese. Stiamo parlando, come si sarà capito, di CLIL: Content and Language Integrated Learning, che spesso si rende con apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
Si tratta anzitutto di metodologia assai poco adottata a livello europeo, nonostante in Italia sia stata sostenuta la menzognera tesi di una “diffusione capillare” nelle scuole continentali: per convincersene, è sufficiente ancora una volta consultare l’ennesimo, recente (2017) rapporto Eurydice Key Data on Teaching Languages at School. Vi si legge testualmente (pag. 55 sgg.): “in nearly all European countries some schools offer CLIL provision (…) The fact that CLIL provision exists in an education system does not necessarily mean that it is widespread within the education system.” L’edizione italiana del rapporto precedente (2012) asseriva con chiarezza:
“Nonostante esista in quasi tutti i paesi ai livelli primario e secondario generale, il CLIL non è molto diffuso nei sistemi educativi.”Solo Cipro (un anno della scuola primaria), Lussemburgo (dalla primaria), Austria (primi due anni di primaria), Liechtenstein, Malta e, naturalmente, l’Italia delle riforme epocali (ultimo anno di secondaria superiore, con l’eccezione dei licei linguistici) prevedono sistematicamente la metodologia CLIL nell’intero sistema educativo ad un qualche livello dei corsi. Nel resto d’Europa, come si è detto, solo some schools…
Per quanto riguarda il livello di competenza richiesto al personale insegnante,dal quale dipende in modo cruciale la reale efficacia dell’innovazione, si è passati dall’iniziale richiesta del possesso di competenze di livello (piuttosto elevato) C1 del Quadro europeo di riferimento per le lingue (D.M. 30 settembre 2011, D.D. n. 6 del 16 aprile 2012), alla successiva richiesta di un inferiore livello B2 (quello che dovrebbe conseguire uno studente della scuola superiore al termine del proprio percorso di studi!) per accontentarsi, in un progressivo e per certi versi tragicomico gioco al ribasso, addirittura del possesso di un livello ancora inferiore, il B1 (sia pure, secondo il costume nazionale, “temporaneamente”: in attesa cioè che l’interessato ottenga la certificazione superiore: Nota Miur n. 4969 del 25 luglio 2014). Questo, evidentemente, di fronte alla totale carenza di personale dotato delle necessarie competenze linguistiche (d’altronde, attaccammo l’Unione Sovietica con l’ARMIR… come andò a finire è noto).
Per comprendere meglio i termini della questione, ecco la descrizione ufficiale (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) delle competenze possedute al livello B2:
il soggetto è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Esiste quindi la concreta possibilità che gli studenti conoscano la lingua meglio dell’insegnante. Il quale, forte della propria capacità di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti nonché di esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni, potrà illustrare compiutamente, in un inglese relativamente sciolto e spontaneo, i fondamenti concettuali della meccanica quantistica, la struttura della Fenomenologia dello Spirito in Hegel, le ragioni storiche, economiche, sociali e geopolitiche che hanno condotto al primo conflitto mondiale. In tutti i casi, s’intende, esponendo i pro e i contro.
In tale quadro, culturalmente desolante, si immagina quindi in maniera dilettantesca un insegnamento veicolato in una lingua che sia il docente sia gli studenti conoscono, diciamo così, in modo alquanto imperfetto. Ma se lo scopo è la discussione critica di idee e concetti, quello scopo potrà essere efficacemente conseguito? C’è da dubitarne, se si pensa che l’abbandono della ricchezza comunicativa in lingua madre può essere assimilato per molti versi all’adozione della Neolingua acutamente descritta da Orwell in 1984come strumento esplicitamente votato al depauperamento del pensiero: “La Neolingua era intesa non a estendere, ma a diminuire le possibilità del pensiero; si veniva incontro a questo fine appunto, indirettamente, col ridurre al minimo la scelta delle parole”. “Tutte le ambiguità e sfumature di significato erano state completamente eliminate”. “Ogni riduzione [del vocabolario] rappresentava una conquista, perché più piccolo era il campo della scelta e più limitata era la tentazione di lasciare spaziare il proprio pensiero”.
Perché impoverire il linguaggio, come per necessità avviene quando si usa un altro idioma, significa ridurre le possibilità di trasmettere pensiero, idee, concetti, sfumature, sottili distinzioni. Vuol dire appiattire mortalmente la ricchezza comunicativa di una buona lezione, che invece si fonda sul gioco delle sfumature, linguistiche ma sempre anche concettuali, dei sensi molteplici, degli esempi, delle interlocuzioni.
Non serve, credo, andare oltre. Alla luce delle suesposte riflessioni, l’estemporanea trovata del CLIL può essere seriamente proposta come metodologia in grado di rafforzare il processo di apprendimento della lingua straniera? Può essere intesa addirittura come strumento in grado di compensare il deficit che verrebbe dal taglio di un anno di corso? Ciascuno risponda con l’onestà intellettuale di cui è capace.
5. Il peccato originale
L’analisi fin qui condotta resta, per così dire, all’interno dell’impianto (pseudo)riformistico che, per quanto è dato capire, si viene delineando. Se le obiezioni che si è tentato di argomentare sono – come riteniamo – serie, a quell’impianto si può e si deve muovere anche una critica più generale, che nuovamente il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (2017) riassume in breve nei seguenti termini:
Nel complesso quadro dell’ordinamento dei cicli, sarebbe opportuna una considerazione complessiva dei curricoli dell’intero ordinamento scolastico nazionale, con una ambizione pedagogico-scientifica più ampia, a partire dalla scuola dell’infanzia, e una visione unitaria e coerente delle caratteristiche e delle finalità del percorso di istruzione.
Sia pure con parole istituzionalmente felpate, l’obiezione è chiara: il programma di tagliare, sic et simpliciter, la durata dei percorsi quinquennali (ché in fondo solo di questo si tratta) manca di una visione di insieme, di una generale riflessione sulle finalità del sistema di istruzione e formazione, di una attento ripensamento della struttura verticale dei curricoli, per tacere delle esigenze pedagogiche ed “esistenziali” dei giovani che ogni anno fanno il loro ingresso in una scuola della Repubblica. Questo il vero peccato originale dell’ennesimo disegno (pseudo)riformatore.
Ma tutto questo è coerente con il già richiamato tramonto di ogni istanza genuinamente pedagogica. In nome di un potente e incontrastato modernismo tecnocratico, viene tacitata ogni voce (erede di una tradizione culturale e filosofica i cui interpreti più esemplari e noti, ma per nulla unici, appartengono alla Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse, ma anche, successivamente, Habermas e Morin) che chieda di considerare come obiettivo primario la formazione di soggetti come individui-persone, uomini e donne “non integrati”, dotati di intelligenza critica, dunque capaci eventualmente di dissentire, di partecipare alla vita sociale e democratica, di comprendere e de-costruire l’interessata narrazione del mondo che ogni potere, in ogni tempo, ha sempre proposto a garanzia della propria autoconservazione.
Ad occupare, vittoriosa, il campo resta una visione, dalla narrazione corrente descritta come necessaria ed inevitabile (“non ci sono alternative”), che pone l’accento soprattutto sulla funzione sociale dell’educazione, che dunque tende a ridursi senza residui alla pura dimensione dell’istruzione: un’istruzione che guarda principalmente e precocemente alle esigenze del mercato del lavoro, della realtà produttiva, della moderna competizione economica internazionale (perenne, come perenne è lo stato di guerra tra le Supernazioni orwelliane in 1984) che ha sostituito, almeno in Occidente, i tradizionali conflitti del passato. L’idea è che per una cittadinanza efficace sia sufficiente, in fondo e al di là di retoriche enunciazioni di principio nei fatti completamente disattese, il possesso di “saperi e tecniche”: non serve molto di più.
E proprio e solo alla luce di questo modello che diventa allora comprensibile la centralità che i “tecnologi dell’istruzione” assegnano enfaticamente alle tecnologie didattiche, all’informatica, alla “didattica del fare”, al multimediale, fino alle altissime più recenti conquiste: il pensiero computazionale e l’alternanza scuola-lavoro. È il modello che pone al centro la competenza, termine non a caso proveniente dal mondo delle professioni e ben poco applicabile al mondo dell’educazione. Qui si esalta la prestazione tecnica, di cui – di nuovo: non a caso – ci si preoccupa spesso di sottolineare il carattere non-ideologico, a-valoriale, eticamente neutro. Ma la sottolineatura è strumentale, perché in campo educativo ogni neutralità è solo apparente (si rilegga l’epigrafe posta in testa a queste brevi riflessioni).
Dunque: esaltazione della “scuola che serve davvero” (salvo non cavare poi molto quando si chieda di declinare in dettaglio che cosa davvero serva…), della scuola “al passo coi tempi” (salvo non porsi mai il problema di capire dove stiano mai andando, questi tempi sempre tanto frettolosi, e soprattutto se davvero valga la pena di seguirne la marcia), della “modernità”, della “velocità”, della “didattica breve”, della compressione frenetica dei tempi per un apprendimento sempre più superficiale, votato ad una rapida spendibilità (e ad altrettanto rapida obsolescenza) in un mercato del lavoro globalizzato e via via precarizzato, cui corrispondono retribuzioni miserrime ma funzionali all’aumento “all’italiana” della competitività del “prodotto” (ove in Paesi evoluti la competitività è ottenuta ricorrendo all’innovazione progettuale e produttiva e agli investimenti a lungo termine in ricerca e sviluppo: strada più difficile e lunga? certo, ma dagli esiti ben più solidi e duraturi).
È questo il brodo di coltura in cui vanno lette, e diventano allora interpretabili, le molte “riforme” degli ultimi tempi, disiecta membra prive di quella visione di insieme cui faceva cenno il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione; solo in questo brodo di coltura, solo in tale devastata temperie culturale, possono essere seriamente proposte innovazioni che di fatto riducono il tempo di formazione dei giovani (ma anche le spese dello Stato), distruggendo un impianto “gentiliano” criticabile fin che si vuole, ma al quale occorre pur riconoscere una concezione unitaria, coerente e formidabile della cultura e delle sue altissime finalità.
6. Ma allora: cui prodest?
La discussione condotta brevemente nelle precedenti pagine sembra autorizzare alcune conclusioni.
Infondata, anzitutto, appare la “metodologia” (ma è qui termine sensatamente impiegabile?) con cui sarà condotta la sperimentazione di riduzione a quattro anni dei percorsi secondari. Sotto il profilo procedurale i protocolli abbozzati appaiono talmente destrutturati, da suscitare seri dubbi sulla validità di ogni conclusione che ne verrà tratta. Di più: l’approssimazione nella delineazione dei percorsi e l’assenza di riferimenti pedagogicamente fondati potrebbe anche indurre taluno al sospetto che si tratti di pura operazione cosmetica, cui a principio non si attribuisce alcuna seria intenzione sperimentale e predittiva.
In ogni caso, la nomina ministeriale dei Comitati che dovranno valutare la sperimentazione certo non esclude in sé, ma neppure garantisce (come invece dovrebbe essere in una ricerca che abbia pretese di scientificità) una piena terzietà e imparzialità nella valutazione stessa: altro non indifferente vulnus procedurale dell’intero impianto progettuale.
Indimostrati i vantaggi pedagogico-didattici di una ulteriore e pesantissima riduzione del tempo scuola (dopo quella conseguente al “riordino” Gelmini-Tremonti del 2010), laddove invece, al contrario, sembrano profilarsi fondate ragioni per ritenere che l’operazione, dovesse essere in effetti realizzata, determinerà una decisiva riduzione dell’offerta formativa destinata ai giovani cittadini italiani ed un generale impoverimento culturale, di cui non si sente davvero l’esigenza. D’altro canto, appare velleitario ogni tentativo di “recuperare” formalmente tale riduzione, facendo ricorso ad artifici didattici ad hoc di assai discutibile e non provata efficacia (anche se – questo occorre riconoscerlo – di buona “presa massmediatica”).
Improponibili poi i riferimenti a “buone pratiche” di matrice estera, a miracolosi e maggioritari “modelli quadriennali” di marca straniera, che simpliciter non esistono: il solo farvi riferimento ha tutto il carattere di operazione di disinformacija con finalità poco chiare (o, a scelta, chiarissime).
Indimostrata (e indimostrabile) la tesi per la quale il termine a 19 anni degli studi secondari (come peraltro accade nella grande maggioranza dei Paesi europei) sarebbe di per sé svantaggioso: in ogni caso, quand’anche fosse (e non è), tale inesistente svantaggio potrebbe facilmente essere colmato facendo cominciare il percorso scolastico a 5 anni di età,come in altre realtà europee o, se proprio si vuole, ripensando l’intero primo ciclo in termini unitari, nell’ottica di quella “riforma dei cicli” proposta dall’allora ministro Berlinguer e frettolosamente accantonata, benché non priva di interesse e di senso pedagogico. Riforma, peraltro, che oggi sarebbe assai facilitata dall’avvenuta trasformazione, pressoché ovunque,di “scuole medie” e “scuole elementari” in istituti comprensivi.
Totalmente inaccettabili i nessi che si vorrebbero strumentalmente stabilire tra “quadriennalizzazione” dei percorsi superiori e innalzamento dell’obbligo di istruzione, quasi che si trattasse di un incommentabile do ut des nel cui ambito, per ottenere qualcosa di giusto (l’innalzamento dell’obbligo scolastico), in concambio si dovrebbe assentire a qualcosa di profondamente errato (il taglio del tempo scuola nel II ciclo): se fosse veramente questo l’obiettivo, l’innalzamento dell’obbligo di istruzione si potrebbe introdurre in tempi brevissimi ope legis (magari con il solito breve comma nella prossima legge di stabilità?) sino al raggiungimento di un diploma secondario, senza che ciò in alcun modo debba comportare, come immorale contropartita, irrecuperabili depauperamenti dell’offerta formativa oggi esistente.
Inefficace, al fine di aumentare il numero di occupati, ogni ipotesi di “quadriennalizzazione” in un Paese che presenta tassi di disoccupazione giovanile drammatici, scandalosi ed inaccettabili (nella fascia 15-24 anni, il tasso di disoccupazione in Italia, a maggio 2017, era pari al 37%; per confronto, in Germania valeva il 6,7%, in Olanda il 9%, nella zona euro il 18,9% [An]). In tali condizioni, la risibile argomentazione di un “ingresso anticipato nel mondo del lavoro” si traduce in un “ingresso anticipato nel mondo della disoccupazione” (al più, della sotto-occupazione precarizzata e sottopagata!). Laddove, al contrario,per la riduzione dei tassi di disoccupazione (giovanile e no)– che ben prima di ogni (pseudo)riforma scolastica dovrebbe occupare prioritariamente l’azione di qualunque governo –,sembrerebbe sensato richiedere più formazione, più istruzione, più investimenti per i giovani, più scuola (e, magari, più rispetto per chi nella scuola quotidianamente opera): non, incredibilmente,meno!
Incomprensibile dunque e, addirittura, autolesionistica l’operazione di “quadriennalizzazione”, nella misura in cui essa comporta un sicuro depauperamento (irrecuperabile a colpi di CLIL, “laboratorialità”, tecnologie didattiche e consimili varie amenità) dei nostri istituti tecnici, scuole di lunga tradizione che licenziano figure professionali di prim’ordine; e del nostro sistema liceale, cui si guarda con interesse anche dall’estero, frequentato da studenti i cui esiti nei test internazionali,almeno in certi contesti geografici, sono superiori alla media Ocse e talora confrontabili con quelli conseguiti dagli studenti dei migliori (si dice) sistemi scolastici del mondo.
Giustificatissimo sarà il lettore che, giunto con pazienza fin qui, si interroghi dubbioso circa le ragioni per le quali sia perseguito il progetto di “quadriennalizzazione”, se tali e tante sono le criticità che sembrano caratterizzarlo sotto una molteplicità di profili.
In proposito lo scrivente, che deve onestamente ammettere la penuria di chiavi di lettura, può solo avanzare alcune ipotesi.
Anzitutto, il taglio dell’ultimo anno di corso presenta una gestione enormemente più semplice rispetto a modifiche che prevedano un ingresso nella scuola anticipato a 5 anni di età o il passaggio ad un I ciclo unico settennale: non è infatti necessario, da parte della struttura amministrativa centrale e periferica, risolvere il grave problema della gestione (aule, docenti, ecc.) del raddoppiato numero di studenti che, in un certo anno scolastico, verrebbero a frequentare la prima classe della scuola primaria. Se si vuole tagliare il percorso che conduce al diploma secondario da 13 a 12 anni, l’eliminazione dell’anno terminale è la soluzione organizzativamente di gran lunga più sbrigativa e meno problematica.
In seconda battuta, si stima che il taglio di un anno nella durata del sistema di istruzione comporterebbe una riduzione del personale della scuola di circa 40.000 unità, con un risparmio stimato in 1.38 miliardi di euro per il bilancio dello Stato.
La riduzione della pianta organica comporterebbe peraltro il vantaggio collaterale di una minore necessità di reclutamento di nuovo personale: si prevede infatti che nei prossimi 10-15 anni raggiungeranno, nonostante penalizzazioni che non hanno eguali in altri Paesi europei, i requisiti pensionistici decine di migliaia di insegnanti del corpo docente italiano, che è d’altronde quello che di gran lunga “vanta” la maggiore anzianità anagrafica d’Europa.
È legittimo che l’esecutivo di turno (irrilevante la colorazione politica: pura vernice superficiale) intenda smantellare l’attuale ordinamento scolastico, con conseguenze negative che si proietteranno nei decenni futuri, per ottenere ulteriori risparmi, peraltro neppure così significativi, nel comparto della pubblica istruzione? È legittimo che l’esecutivo di turno decida di ampliare il taglio di 8 miliardi di euro già inflitto al bilancio del Miur ai tempi del “riordino” Gelmini-Tremonti di inizio decennio? Certamente, è legittimo: basta che non ci si nasconda dietro a improbabili foglie di fico e si intèstino con chiarezza sperimentazioni e (pseudo)riforme epocali non tanto al Miur, a questo punto mero esecutore di politiche decise altrove, ma al ministero dell’economia e delle finanze, a sua volta impegnato a svolgere con diligenza i “compiti” assegnatigli dai maestri d’oltralpe, pena il subitaneo aumento dei costi di rifinanziamento del debito pubblico (con minaccia di default), secondo un copione che ha dato così buona prova di sé già nel 2011 (e, come noto, al progressivo smantellamento dello stato sociale, che tanto impatta sulla qualità della vita dei ceti meno abbienti, “non c’è alternativa”).
Siano poi i cittadini elettori, correttamente informati, a decidere con cognizione di causa quanto sia giusto e accettabile che si faccia cassa risparmiando sulle possibilità di formazione dei propri figli (quegli stessi cittadini nel contempo continueranno a finanziare gli istituti con “contributi volontari”, grazie ai quali le scuole possano garantire, inter alia, la carta per le fotocopiatrici e quella, ormai quasi proverbiale, per… la toilette).
Conclusioni
Bisogna essere onesti: il decreto di sperimentazione, triste erede di precedenti, velleitari conati “riformatori” rimasti lettera morta, evidenzia sì abissali criticità, ma nel contempo presenta anche un innegabile pregio: quello di rendere manifesta con assoluta chiarezza la strada che, in un futuro non tanto lontano e in assenza di decise reazioni della società civile, si intende far imboccare a questo Paese. Nessuno potrà dire: a quel tempo, non avevo capito.
A chi volesse riconoscere validità alle argomentate ragioni di critica addotte in questa sede, nel breve rimane pur sempre una speranza: che i collegi dei docenti, autonome comunità professionali chiamate un giorno molto prossimo ad esprimersi sul progetto,memori delle prerogative in materia pedagogico-didattica ad essi attribuite dalla legge (D.lgs. 297/94 art. 7 c. 2 lett. f), sappiano opporre alle effimere lusinghe di una devastante modernità di cartapesta un dignitoso, tranquillo, semplice e motivato: no, grazie.
[1]senza alcuna pretesa di esaustività: L. 107/15 c. 7 lett. i); DPR 87/10 art. 5 c. 2 lett. d), che fa riferimento a misteriosi stili di apprendimento induttivi [sic]; DPR 88/10 art. 5 c. 2 lett. e); DPR 89/10 art. 8 c. 1 (il riferimento è al liceo scientifico; per la precisione, qui si parla di pratica laboratoriale). Ora all’elenco si aggiunga il decreto di sperimentazione.
[2]l’adesione a questa impostazione da parte del ministero dell’istruzione è attestata dal ventennale florilegio di iniziative a sostegno della didattica digitale, variamente declinate: dal Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (dell’ormai lontano 1997, persino prima che gli Obiettivi di Lisbona del Consiglio europeo del 2000 diventassero la nuova indiscutibile Bibbia dell’educazione comunitaria), al progetto ForTic, dal progetto DidaTec a quello Cl@ssi 2.0, dal Patto per la Scuol@ 2.0 fino al recente (epocale) Piano Nazionale Scuola Digitale (notare la magistrale monotriade di acronimi, lingua inglese e accattivanti simboletti informatici: occorre ammettere che sarebbe difficile dare vita a sintesi migliore). Il decreto di sperimentazione mette ora a frutto, con coerenza e consequenzialità, tale impareggiabile tesoro di esperienze.
[3]per gli istituti tecnici cfr. DPR 88/10 art. 8 c. 2 lett. b), dove la lingua è l’inglese; per il licei cfr. DPR 89/10 art. 10 c. 5, dove si parla di “insegnamento in lingua straniera”.
[FW] T. Fuchs, L. Wößmann, Computers and student learning: bivariate and multivariate evidence on the availability and use of computers at home and at school, CESifo Working Paper n. 1321 (novembre 2004). Il testo è reperibile sul sito www.cesifo.de.
[Ho] D. Hodson, Una visione critica dell’attività pratica nell’insegnamento delle scienze sperimentali, La Fisica nella Scuola n. 3 (1992).
[OCSE] http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm In particolare, cfr. cap. 6 How computers are related to students’ performance.
[Sp] M. Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio 2013
 Send to Kindle
Send to Kindle